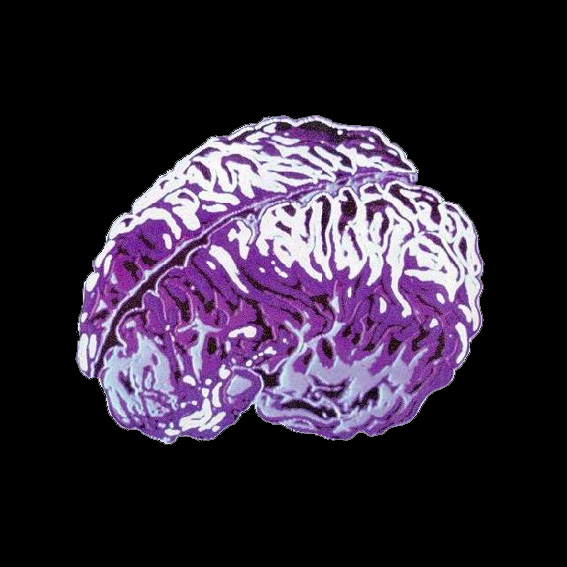Percezioni del corpo e percezioni del pensiero
Percorso di citazioni con intervento (provocatorio)
d’artista
“Fra le
percezioni che sono causate dal corpo, la maggior parte dipende dai nervi;
ma ce ne sono pure alcune che non ne dipendono affatto e che vengono
chiamate immaginazioni, come quelle di cui ho ora parlato, da cui
differiscono nondimeno in questo, che la nostra volontà non si adopra a
formarle: per questo non possono essere messe nel numero delle azioni
dell’anima. Esse derivano soltanto dal fatto che gli spiriti, essendo
diversamente agitati e incontrando le tracce di diverse impressioni
precedenti nel cervello, prendono fortuitamente il loro corso per certi
pori piuttosto che per altri. Tali sono le illusioni dei nostri sogni,
nonché le fantasticherie che spesso abbiamo da svegli, quando il nostro
pensiero erra con abbandono, senza applicarsi a niente per se stesso”. (Cartesio, Le passioni dell’anima
“D’altra
parte si è costretti a confessare che la percezione e ciò che ne dipende
non si possono spiegare con ragioni meccaniche, cioè mediante le figure e
i movimenti. E immaginando che vi sia una macchina la cui struttura
permetta il pensare, il sentire, l’aver percezioni, si potrà concepirla
ingrandita con le medesime proporzioni, in maniera che ci si possa entrare
come in un mulino. Posto ciò, visitandola all’interno, non vi si
troveranno che parti le quali spingono le une le altre, ma non mai
qualcosa con cui spiegare una
percezione” (Gottfried Wilhelm
Leibniz, Monadologia, tr. it. di G.Preti, Milano, Bruno Mondadori, 1995,
17° tesi, p.32
“Io
devo avere un corpo, è una
necessità morale, un’”esigenza”. E, in primo luogo, io devo avere un corpo
perché vi è qualcosa di oscuro in me. Ma, fin da questo primo argomentare,
l’originalità di Leibniz appare grande. Egli non dice che solo il corpo
spiega quanto c’è di oscuro nello spirito. Al contrario, lo spirito è
oscuro, il fondo dello spirito è oscuro, ed è proprio questa natura scura
che spiega ed esige il corpo” (Gilles Deleuze, La piega. Leibniz e il
barocco, tr.it. di V.Gianolio, Torino, Einaudi, 1990, p.127
“Restituire
il pensiero alle forze “corporanti” (agli impulsi), equivaleva a
espropriare il supporto, l’io; tuttavia, proprio con il suo cervello Nietzsche effettua
tale restituzione e tale espropriazione, così esercitando la sua lucidità
per penetrare le tenebre: ma come si può restare lucidi se si distrugge il
focolaio della lucidità, ossia l’io?” (Pierre Klossowski, Nietzsche e il
circolo vizioso, tr.it. diE.Turolla, Milano, Adelphi, 1981, p.
62
“Segno di sé e esser-sé del segno: questa è la
duplice formula del corpo in tutti gli stati e in tutte le possibilità che
gli riconosciamo (…). Il corpo si
significa in quanto corpo
(dell’) interiorità sensata: basta vedere tutto ciò che si fa dire al
corpo umano, alla sua stazione eretta, al suo pollice opponibile, ai suoi
“occhi in cui la carne si fa anima”(Proust). Così il corpo presenta
l’esser-sé del segno, la comunità compiuta del significante e del
significato, la fine dell’esteriorità, il senso nel sensibile –hoc est enim
Tutte le
nostre semiologie, tutte le nostre mimologie, tutte le nostre estetiche
tendono verso questo corpo assoluto, verso questo corpo iper-significante,
corpo del senso nel senso del corpo. Ogni funzione simbolica vi si compie: riunione
sensibile delle parti dell’intelligibile, riunione intelligibile delle
parti del sensibile (…). Ed è proprio qui che il corpo dilegua: per poter
raggiungere questo culmine della significazione, “il corpo” è stato
continuamente teso, esasperato, dilacerato fra innominabile e
innominabile: tanto più straniero quanto più intimo. Il corpo è l’organo del senso: ma il senso
del senso è quello di essere l’organo (o l’órganon), assolutamente (…). Il corpo non è, quindi,
nient’altro che l’auto-simbolizzazione dell’organo
assoluto. Innominabile come Dio, esso non espone niente nel fuori di
un’estensione, ma è organo dell’organizzazione-di-sé, innominabile come la putrefazione dell’autodigestione (la Morte in
Persona), e anche come quella costruzione dell’intimo tessuto del sé, cui
si adopera una filosofia del “corpo proprio” (“ciò che chiamiamo carne,
questa massa agitata all’interno non ha nome in nessuna filosofia” –
Merleau Ponty). Dio, la Morte, la Carne: triplice nome del corpo di tutta
l’onto-teologia. Il corpo è la combinatoria esaustiva, l’assunzione comune
di questi tre nomi impossibili in cui si esaurisce ogni significazione”
(Jean-Luc Nancy, Corpus, tr.it. di
A.Moscati, Napoli, Cronopio, 1995, pp. 61-62
Non
armeggiai dunque con plastiche, transistor e altri hardware. Presi del
materiale adatto – DNA, protoplasma – e mi misi al lavoro. A dire la
verità, non fu così difficile crearlo. Dopo tutto ero bravo. Creai
direttamente una persona già cresciuta e mentalmente sviluppata. Poiché mi
piaceva l’idea di usare le vocali per i nomi, lo chiamai “A”
Finché
la mia creazione non volle altra compagnia oltre alla mia. La cosa mi
spiacque, se devo dire la verità. Pertanto (se devo dire proprio tutta
la verità) me la sbrigai alla svelta. Invece di creare un’altra persona
con una propria vita mentale ed emotiva, creai una macchina che simulasse
perfettamente il comportamento di una persona. La chiamai con la vocale
successiva “E”. Naturalmente
A non sospettò nulla. (…) Tutto
andò avanti bene finché non decisi che A non era una buona compagnia. La
ragione, naturalmente, era che A era troppo stupido. Non era piacevole
avere a che fare con qualcuno che poteva venire ingannato con tanta
facilità. Così pensai di creare un’altra persona più adatta a farmi
compagnia; una persona che non potesse venire indotta a pensare che
un simulatore fosse una persona (…). Pensai quali caratteristiche avrebbe
dovuto possedere un essere simile (…). Ebbi a quel punto l’idea più
ovvia: dare alla nuova persona il dono della telepatia. Una persona
telepatica sarebbe stata in grado di sperimentare direttamente le esperienze
altrui nello stesso modo in cui sperimentava la propria (…). Mi misi
al lavoro con impazienza. Non era troppo difficile creare un essere
telepatico (…) finché mi resi conto che a questo rivelatore di falsi
avrei dovuto fornire non solo l’abilità telepatica di sperimentare qualsiasi
esperienza posseduta da ciò su cui si concentrava, ma anche qualche
mezzo per sapere se ciò su cui si era concentrato possedesse anch’esso quelle esperienze (…).
Gli fornii allora più pensiero, ma senza ottenere nulla. (…) Una persona
qualunque avrebbe ammesso il proprio fallimento e avrebbe deciso che
non era in grado di costruire un rilevatore. Ma io non sono affatto
una persona qualunque. (…) Mi guardai attorno in cerca di un approccio
meno ortodosso ed ebbi la brillante idea di inserire nel rivelatore
come mezzo per distinguere le persone dalle simulazioni, la stessa tecnica
da me usata per raggiungere quello scopo; la tecnica cioè che io stesso
utilizzavo per dire che A era
una persona ed E