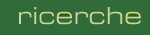Ermeneutica
e traduzione.
L'altro, lo straniero, l'ospite
di Domenico
Jervolino
Una delle tre direzioni nelle quali
va ricercato il senso del greco hermeneuein, accanto ad "affermare,
esprimere" e a "interpretare, spiegare", è "tradurre,
fare da interprete", come sottolinea lo Ebeling nella sua nota
voce enciclopedica "Hermeneutik" (1). Peraltro, nella sede
di questo nostro convegno, l'accostamento fra "ermeneutica"
e "traduzione" non risponde tanto all'esigenza di una storia
del termine, che è stata già fatta prima e meglio
di quanto io non possa fare di nuovo; mi propongo, piuttosto, di accostare
due fenomeni così come sono colti nell'esperienza comune e caratterizzati
nel linguaggio ordinario : la pratica del tradurre in tutte le
sue forme e l'interpretare come oggetto di riflessione teorica che nel
nostro secolo ha assunto un ruolo sempre più centrale nella filosofia
o quantomeno in rilevanti espressioni della filosofia dei nostri tempi,
con l'ambizione di essere assai più di un'arte ausiliaria, anzi
di presentarsi come una disciplina fondamentale e universale, qualcosa
come l'antica filosofia prima.
Fino a che punto tali ambizioni siano
fondate, lo lasciamo per ora da parte. Ci concentriamo invece sul fatto
che il tradurre costituisce quantomeno una delle pratiche interpretative
di cui l'ermeneutica filosofica rappresenta l'elaborazione teoretica.
Il nostro problema è di vedere fino a qual punto il tradurre
possa far luce sull'interpretare in quanto tale. Possa essere, in altri
termini, un esempio illuminante, un paradigma per una filosofia del
linguaggio e dell'interpretazione. Dico: del linguaggio e dell'interpretazione,
perché il linguaggio nel senso più ampio della parola
è il primo presupposto di ogni possibile interpretazione, in
quanto solo ciò che viene al linguaggio può essere interpretato.
Non nel senso che le espressioni linguistiche siano il solo oggetto
dell'interpretare e che quest'ultimo si chiuda nell'ambito del linguaggio,
che diventerebbe così una sorta di prigione magari dorata dalla
quale sarebbe poi difficile uscire. Ciò che è linguisticamente
mediato è tutto ciò il linguaggio dice, quindi ciò
che è altro dal linguaggio, ciò di cui si parla quando
si parla, e si ascolta, si scrive e si legge (o si tenta di....). Questo
altro dal linguaggio è la posta in gioco dell'interpretazione :
essa può essere ulteriormente caratterizzata come l'insieme delle
"cose" o dei fenomeni che ci circondano, in mezzo a cui siamo,
che si manifestano nella nostra esperienza e nella nostra vita, e fra
queste cose o fenomeni noi stessi e gli altri con cui parliamo o di
cui parliamo.
Un vecchio adagio, che peraltro richiede
almeno una chiosa (2), afferma : in claris non fit interpretatio.
I fenomeni, e noi fra essi, hanno bisogno di essere interpretati proprio
perché essi non si manifestano in compiuta chiarezza, perché
il loro senso è almeno parzialmente indeterminato, ma anche perché
possono essere portati a chiarezza e apparire per quello che essi sono
nella loro verità, per quanto limitata, parziale, perfettibile,
ma che è comunque altra cosa da una vana apparenza o da un mero
gioco di specchi (interpretazioni che non sono altro che interpretazioni
di interpretazioni e così all'infinito...). Ed è proprio
il fatto che le cose possano essere "nominate" che custodisce
e attesta la loro verità (umana e non assoluta, un gioco di luci
e ombre, per riprendere la metafora della luce). La parola è
allora l'arca nella quale le cose sono custodite, l'arca che
offre ospitalità alle cose del mondo, secondo l'interpretazione
del mito biblico (Adamo che assegna a ciascuna cosa il suo nome, l'arca
di Noè che salva una coppia di ogni specie vivente) da parte
del fenomenologo francese Jean-Louis Chrétien (3).
Il nome biblicamente come arca o, se
si preferisce, aristotelicamente come entelechìa del fenomeno,
secondo la felice formula del discepolo russo di Husserl, Gustav pet
(4).
Il linguaggio dunque come mediazione
necessaria e non necessitante tra uomo e mondo, come venir alla luce
contemporaneo dell'essere detto o dicibile delle cose e del poter dire
dell'uomo, come inaugurazione di una vita significante, come lumen
naturale del quale si può dire in modo fenomenologicamente
corretto che illumina ogni uomo che viene al mondo e che grazie ad esso
ogni fenomeno av-viene, acquista visibilità, nel mondo.
Eppure, se tale è la funzione
del linguaggio, il linguaggio stesso non esiste al di fuori di una pluralità
di lingue, che si presenta a prima vista come dispersione disarmante
e irrimediabile. Un solo linguaggio, molte lingue. Migliaia di lingue,
ancor più numerose se si contano, oltre le lingue oggi viventi
e le loro varianti, le lingue morte e tra le morte quelle scomparse
senza lasciare tracce o solo tracce minime della loro esistenza passata.
La tentazione di risolvere questa antinomia speculativamente attraverso
una dialettica concettuale fra le categorie dell'uno e dei molti, non
è certo ignota alla storia del pensiero. Frutto di questa dialettica,
l'idea di una lingua perfetta o universale, che rappresenterebbe l'essenza
pura della lingua, al di là delle innumerevoli particolarità
delle lingue storiche. Ma queste ultime restano e la loro diversità
irriducibile condiziona e dissolve ogni sogno di purezza ideale.
E qui, in questo iato fra linguaggio
e lingue (un'opposizione esprimibile con immediata evidenza in italiano
e in altre lingue neolatine, che in altre lingue si condensa per così
dire in una sola parola, ma che comunque riesce ad essere pensata ed
espressa in vario modo), è in questo iato che s'inserisce la
pratica e la problematica della traduzione.
Qui, come filosofi, abbiamo tutto da
imparare dalle dotte analisi di linguisti e semiologi, storici delle
lingue e delle culture, filologi antichi e moderni, romanisti, germanisti,
slavisti, orientalisti, storici e teorici della letteratura e della
critica letteraria, esegeti della Bibbia ebraica e cristiana, commentatori
del Talmud e del Corano, antropologi e storici delle religioni, ecc.
che ci forniscono ormai una bibliografia amplissima, una storia articolata
dei termini, una semantica della traduzione e del tradurre. Fare dei
nomi significherebbe rischiare di peccare per omissione. Ma forse si
può rischiare di citare almeno uno per tutti, un autentico classico
dei nostri giorni in tale materia, quale è After Babel di
George Steiner, del 1975, la cui seconda edizione inglese, sulla quale
è condotta la traduzione italiana che utilizzeremo, risale al
1992. Nel frattempo il testo inglese è stato ripubblicato nel
1998 (5).
Si può parlare, nella seconda
metà del Novecento, ormai di una vera e propria scienza della
traduzione o traduttologia, o quanto meno, più prudentemente,
di un campo di Translation Studies, con antenati illustri
da Cicerone a Lutero, e, più vicini a noi, Goethe, Humboldt e
Schleiermacher, una disciplina o un'area disciplinare che avrebbe, se
lo volesse, anche un patrono celeste in san Gerolamo, autore, oltre
che della Vulgata, dell'epistola a Pammachio De optimo genere
interpretandi.
Se si accetta l'idea di una scienza
della traduzione nata solo negli anni Quaranta del nostro secolo (e
io qui sarei tentato di sottolineare la presenza di un paradigma di
tipo comtiano del passaggio dalla filosofia alla scienza) o comunque
se si prende atto dello straordinario sviluppo degli studi contemporanei
sulla traduzione, bisogna comunque aggiungere che essi sono preceduti
da una lunga fase storica nella quale si trovano importanti meditazioni
sull'argomento, senza però la pretesa di costituire una disciplina
specifica : gli ultimi grandi battitori liberi della riflessione
sulla traduzione quindi sarebbero nel nostro secolo Croce e Ortega (Miseria
y esplendor de la traducción), Rosenzweig (con la nota affermazione :
"Il traduttore è servo di due padroni") e Benjamin
(col suo mirabile saggio su Il compito del traduttore e il suo
concetto messianico di una lingua pura di cui noi riusciamo solo a cogliere
qualche brandello).
"La traduzione, scrive Gianfranco
Folena, è una forma fondata sull'arbitrarietà e sulla
bipolarità del segno linguistico, cioè sulla tensione
fra due funtivi, nel senso che solo il significato è trasmissibile
in lingue, e anche in certa misura, in sistemi semiotici diversi mediante
nuovi significanti, in base al principio della non equivalenza delle
singole unità costitutive e della equivalenza complessiva dei
messaggi (equivalenza non significa identità neppure per il senso)
nei codici diversi. La forma più immediata ed elementare di traduzione
[...] è quella orale, reversibile, impostata sulla comunicazione
a tre, dove fra gli interlocutori, emittente e destinatario, si situa
l'intermediario, o fra due messaggi equivalenti, quello dell'emittente
e quello del destinatario, un commutatore dei due codici rispettivi.
Nella tradizione occidentale il tecnico della traduzione orale ha ricevuto
per lo più un nome speciale, che poi è stato esteso anche
alla fenomenologia scritta e culturale : in greco hermeneus,
parola attestata fin da Pindaro, che ha resistito a tutti i tentativi
'ermeneutici' e resta di etimo misterioso anche nei suoi collegamenti
col nome di Hermes, Ermete, in cui qualcuno volle vedere il dio
interprete, mediatore ; e sembra attinta ad una lingua dell'Asia
Minore, dove i Greci così poco aperti con pochissime eccezioni
al plurilinguismo e al riconoscimento delle lingue 'barbare', giudicate
inferiori e inintelligibili, vennero dapprima e più intensamente
in contatto orale con lingue di struttura tanto diverse. Il dinamismo
semantico della famiglia di hermeneus poggia su questa base,
col senso di una penetrazione profonda dell'ignoto. Invece il latino
interpres -etis è originale elaborazione di materiali
latini (il secondo elemento del composto è certamente connesso
con pretium), proveniente dalla sfera economico-giuridica, cioè
in origine 'mediatore, sensale, arbitro del prezzo'[...]" (6).
Il Folena sottolinea, nel suo dottissimo
contributo, che costituiva originariamente una relazione a un convegno
triestino del 1973, che per la traduzione scritta il quadro terminologico-culturale
è assai più complesso e che è caratterizzato e
reso dinamico dal rapporto fra traduzione e tradizione, antico e moderno.
Il problema della traduzione scritta è più importante
perciò per i Latini che per i Greci, proprio perché i
primi avevano un problema di rapportarsi all'eredità greca :
così avverrà tutte le volte che ci si porrà il
problema di un rapporto con una cultura altra, piuttosto che affermare
orgogliosamente la propria autosufficienza. Molte grandi letterature
moderne in effetti hanno richiesto prima di affermarsi un enorme lavoro
di traduzione dai classici o da lingue straniere già accreditate.
Di qui anche il definirsi nell'ambito
della latinità di una molteplicità forme verbali specifiche
per il tradurre per iscritto, come vortere o vertere,
coi derivati convertere e transvertere, imitari, exprimere,
reddere, mutare, transferre. Quest'ultimo dà origine ai derivati
participiali romanzi translatare, translater, di
cui avvertiamo l'eco ancora oggi nell'inglese to translate. La
complessità di questa rete di forme verbali è accentuata
dal fatto che viene usato per la traduzione scritta per estensione anche
interpretari e la relativa famiglia.
Di qui ancora il definirsi di due campi
semantici vicini ma non identici in italiano come in altre lingue moderne
per la traduzione orale e quella scritta. Nel senso professionale dei
due termini ancora oggi nell'italiano corrente - e non solo in esso
- l'interprete e il traduttore sono figure diverse. E' sempre il Folena
ad aver valorizzato la figura dell'umanista quattrocentesco Leonardo
Bruni, come il primo trattatista moderno della traduzione col suo De
interpretatione recta (ca. 1420) e come colui che introduce il termine
di "traducere" per indicare un concetto unitario di traduzione.
Il Mounin, dal canto suo, rileva che il termine di traducteur in
francese è un italianismo, usato per la prima volta nel Cinquecento
dall'umanista Etienne Dolet (7).
Questa storia semantica ci conduce alle
soglie della Modernità. Non possiamo certo dimenticare il ruolo
determinante, che abbiamo già evocato sopra, svolto da grandi
traduzioni per la nascita e lo sviluppo delle identità linguistiche
e nazionali dei Moderni. La Bibbia di Lutero costituisce un esempio
insigne di tale funzione, ma non è il solo. Si potrebbero ancora
ricordare altre grandi traduzioni della Bibbia (quella ceca dei Fratelli
Moravi, la Bibbia di Ginevra, the King James Version in Inghilterra),
ma anche le traduzioni dei classici antichi e degli autori moderni di
maggiore prestigio (e il ruolo formativo che tali traduzioni ebbero,
ad esempio, nel caso della Germania, nel periodo fra Illuminismo e Romanticismo).
Da questa storia si potrebbe concludere che il problema della traduzione
è un problema moderno per eccellenza che si confonde con quello
della Modernità. Ma la coscienza moderna non è soltanto
l'affermazione dell'autonomia dei Moderni in relazione agli Antichi.
Essa non nasce soltanto per la duplice appropriazione di una autenticità
cristiana evangelica e della lezione dei Classici con un convergente
effetto di emancipazione umana. La nascita della Modernità è
legata, nella coscienza europea, in un modo più stretto di quanto
noi siamo disposti a riconoscere, all'incontro con l'altro extra-europeo.
I grandi viaggi, le grandi scoperte, le conquiste violente degli altri
continenti ci pongono dei problemi di traduzione in un senso più
ampio e più drammatico. Ricordiamo, per completare questo quadro
problematico che il 1492 è nello stesso tempo l'anno della scoperta
dell'America (e avvio della sua conquista) e l'anno della conquista
di Granada (compimento della Reconquista cristiana della Spagna ) e
dell'espulsione degli Ebrei dala Spagna; esso coincide dunque con la
rimozione dall' identità europea - almeno dall'identità
di una certa Europa - di un "altro" che tuttavia resta silenziosamente
presente nella sua assenza.
Questo groviglio di problemi è
legato alla questione filosofica della traduzione in tutta la sua ampiezza.
Dal nostro punto di vista, dopo cinque secoli di storia moderna, la
questione della traduzione manifesta la sua complessità a motivo
della tensione immanente al concetto stesso di traduzione, nel quale
si può distinguere un senso ampio e uno ristretto: parlare è
già tradurre e inoltre v'è il dato della pluralità
delle lingue. Si è tentati di dire che v'è pluralità
delle lingue perché noi siamo originariamente plurali.
Ritorniamo ai nostri giorni, e in particolare
allo Steiner : nel suo grande volume sulla traduzione troviamo
un concetto allargato della traduzione : "Ogni modello di
comunicazione è al tempo stesso un modello di tra-duzione, di
trasferimento verticale o orizzontale di significato. Non vi sono due
epoche storiche, due classi sociali o due località che si servano
delle parole e della sintassi per significare esattamente le stesse
cose, per inviare segnali identici di valutazione e deduzione. E nemmeno
due esseri umani. [...] Si parla per comunicare. Ma anche per nascondere,
per non dire. La capacità degli esseri umani di trasmettere informazioni
errate o inesatte possiede un ampio spettro di variabilità dalla
menzogna esplicita al silenzio. Tale capacità si basa sulla struttura
duale del linguaggio : il nostro discorso esterno ha 'alle sue
spalle' un flusso corrispondente di coscienza articolata. [...] Nella
maggior parte degli scambi sociali convenzionali, il rapporto fra queste
due correnti di discorso è solo in parte congruente. Vi è
doppiezza. [...] Un essere umano compie dunque un atto di traduzione,
nel pieno senso del termine, quando riceve un messaggio verbale da qualsiasi
altro essere umano" (8).
Una consapevolezza acuta della difficoltà
e della problematicità del tradurre attraversa la grande opera
dello Steiner. La traduzione in senso stretto, da lingua a lingua, conferma
e rafforza una problematicità che è immanente in ogni
scambio di significato, nella traduzione in senso largo. Il numero enorme
delle lingue e la loro diversità costituiscono un vero spreco
per una umanità che è invece sostanzialmente omogenea
dal punto di vista biologico e psicosomatico.
Ci troviamo di fronte a una vera e propria
galassia di lingue che non risponde ad alcun principio definibile e
contraddice i più elementari criteri di economia. Né la
dispersione geografica costituisce un criterio ordinatore o una motivazione
plausibile. Lingue parlate da una sola tribù, da un solo villaggio,
incomprensibili ai popoli vicini. La polverizzazione linguistica degli
umani sembra un enigma tale da rendere in qualche misura plausibile
il ricorso a spiegazioni mitiche, come quella della biblica Babele che
trova riscontro in altri miti analoghi presso altre culture.
Babele, quindi, come condanna alla
confusione e alla dispersione, prezzo del peccato di orgoglio, nuova
cacciata dall'Eden di una lingua unica, di una comunicazione senza intoppi.
Babele come disastro originario, anche se il potere formativo della
lingua, la sua forza poetica e creativa, di cui riusciamo a cogliere
come delle scintille o degli sprazzi di luce tutte le volte che si ha
comprensione, fa sì che il disastro diventi - secondo l'etimo
suggerito da Steiner - una "pioggia di stelle" sull'umanità.
La traduzione diventa una sorta di rimedio
rispetto a una condizione decaduta dell'umanità; essa nasce da
un atto di fiducia iniziale: qui c'è un senso da recuperare.
Una fiducia che può terminare nello scacco: qui non c'è
nulla da capire. Ma, comunque, il seguito della fenomenologia della
traduzione assume sempre più l'andamento di un conflitto, di
una guerra. Alla fiducia, infatti, segue l'aggressione : la seconda
mossa del traduttore è un atto di incursione e di estrazione :
la comprensione dell'altro come atto intimamente violento (qui Steiner
richiama Hegel e Heidegger, ma anche San Gerolamo che ricorre alla metafora
del significato fatto prigioniero e riportato a casa dal traduttore).
La terza mossa è l'incorporazione dell'altro nel nostro mondo
linguistico e culturale. Qui il tradurre si rivela ancora più
pericoloso e violento: a questo punto siamo sbilanciati, abbiamo sottratto
qualcosa all'altro e l'incorporiamo in ciò che ci è proprio.
Occorre compensare questo sbilanciamento: "L'atto ermeneutico deve
essere compensativo. Se vuole essere autentico deve trasformarsi in
scambio e ristabilire la parità. L'attuazione della reciprocità
per ristabilire l'equilibrio, deve trasformarsi in scambio e ristabilire
la parità. L'attuazione della reciprocità per ristabilire
l'equilibrio è il fulcro del mestiere e della moralità
della traduzione" (9). "La traduzione ristabilisce l'equilibrio
tra se stessa e l'originale, tra la lingua originale e la lingua d'arrivo,
equilibrio spezzato dall'attacco e dall'appropriazione interpretativa
del traduttore. Il paradigma della traduzione rimane incompleto finché
non si raggiunge la reciprocità, finché l'originale non
ha recuperato quanto ha perduto" (10). Questo compito alla fine
si rivela pressoché impossibile: si può sbagliare per
eccesso o per difetto. La disamina delle traduzioni inglesi del brano
omerico in cui Priamo va da Achille a chiedere le spoglie di Ettore
è un pezzo di bravura che mostra tutta la grandezza del critico
e storico della letteratura. La conclusione di Steiner è che
la traduzione perfetta non esiste, ma che ci sono degli esempi di traduzione
che si avvicinano alla perfezione.
Questa conclusione quasi scettica a
livello della traducibilità della grande poesia viene in qualche
modo recuperata dallo Steiner ritornando a un concetto allargato di
traduzione : il linguaggio, la cultura, la comunicazione sono in
effetti processi di traduzione, che comportano o la trasformazione di
messaggi entro lo stesso sistema di segni verbali (in questo caso parliamo
con Jakobson di "riformulazione", rewording) oppure
il passaggio da un sistema di segni verbali a un sistema di segni non
verbali (ciò che Jakobson chiama transmutation, transmutazione).
L'ermeneutica comporta lo studio della traduzione, della sua possibilità
e dei suoi limiti. Eppure una teoria, in senso stretto, della traduzione
non c'è per Steiner, vale a dire per l'autore di quello che può
considerarsi probabilmente la più importante opera sulla traduzione
del nostro secolo. La traduzione è per lui - con una espressione
volutamente paradossale che riprende da Wittgenstein - un'arte esatta.
Ogni lingua è un mondo possibile, nella lingua si realizza come
una trasfigurazione del destino biologico, mortale dell'individuo. Tutti
i tentativi di giungere all'uniformità - dal formalismo estremo
di certa linguistica generativa a quello che egli chiama l'esperanto
angloamericano che invade il mondo tardocapitalista - sono da lui fortemente
criticati. Resta l'immagine della pioggia di stelle sull'umanità.
Un'immagine di bellezza, che ricorda un po' la "nostalgia del totalmente
altro", l'utopia della lingua pura, perfetta, pre-babelica nel
mondo post-babelico.
Ma la lettura del mito di Babele che
vede nella molteplicità delle lingue una condanna e una maledizione
è la sola possibile ? Oppure si dà una possibilità
di intendere positivamente la pluralità delle lingue, a partire
da una lettura diversa dello stesso racconto biblico ? Il pluralismo
linguistico non sarebbe, allora, una condanna e una maledizione, ma
significherebbe la rinuncia al sogno totalizzante di una lingua perfetta
(e di una traduzione globale e, per così dire, senza residui).
La parzialità e la finitezza delle singole lingue diverrebbe,
allora, non un ostacolo insormontabile, ma la condizione stessa del
comunicare possibile fra gli umani. In tale direzione va il bel libro
di François Marty, che pur comportando una reinterpretazione
del testo biblico, è un lavoro fondamentalmente filosofico di
meditazione sulla natura del linguaggio (11) e, in modo più problematico,
il denso contributo postumo del grande studioso francese di poetica
e di storia letteraria Paul Zumthor (12).
È significativo che il saggio
di Marty si apra con la citazione della pagina iniziale della Dottrina
trascendentale del metodo della Critica della Ragione pura nella
quale Kant accenna al racconto di Babele, invitando gli esseri umani
a rinunciare alla pretesa di costruirsi una torre per accontentarsi
di una abitazione più modesta, ma sufficiente ai loro bisogni.
Jaspers nel suo volume I grandi filosofi riprende questa pagina
kantiana, alla fine del lungo saggio su Kant, dicendo del filosofo di
Könisberg che egli si è costruita una casa ai margini della
strada per riposarvi, ma che né lui né noi dobbiamo fermarci
per sempre in essa, ma dobbiamo riprendere il nostro cammino (13).
Siamo riportati dunque dalla trasgressione
superba del limite simboleggiata dalla torre, alla modestia dell'abitare
e alla perseveranza della vita come cammino, alle due immagini della
casa e della via, evocanti la finitezza spaziale e temporale della condizione
umana. Duplicità di dimensioni che si ritrovano, nel linguaggio,
nella duplicità dell'asse del sintagma e dell'asse del paradigma.
Bipolarità strutturale del linguaggio che diventa empirica pluralità
delle lingue, al limite dei singoli individui parlanti come monadi che
pure comunicano fra di loro.
Qui si potrebbe ricordare un saggio
di Ricoeur del 1971 su "Discorso e comunicazione" in cui si
afferma che la comunicazione intermonadica se per il linguista e gli
scienziati del linguaggio è un fatto, essa diventa un enigma
per il filosofo che deve ricostruire pazientemente, partendo da una
messa in questione radicale (che fa rivivere, a mio avviso, il gesto
dell'epoché fenomenologica) ciò che si comunica
- il significato, con i suoi vari strati - senso e referenza, gli atti
linguistici, le intenzioni noetiche, in breve ciò che con Beneveniste
e Ricoeur possiamo chimare l'íntenté, l'intento,
del discorso, la parte intenzionale della vita - sullo sfondo di ciò
che non può essere comunicato perché è ciò
che della vita è singolarità irripetibile, e che Ricoeur
chiama lo psichico (14).
Finitezza dell'umano, bipolarità
del linguaggio, unità in tensione fra singolarità e intenzionalità
del vivere : forse tutte facce diverse della stessa realtà,
nelle quali si ripropone continuamente la dialettica dello stesso e
dell'altro, dell'altro nel cuore stesso dello stesso.
Bipolarità del linguaggio, bipolarità
dell'umano: con Maine de Biran potremmo ripetere: Homo simplex in
vitalitate, duplex in humanitate.
Alla ricerca di questa tensione bipolare
- bipolarità che è propria a una dialettica finita, che
trova sempre solo mediazioni imperfette, che non si chiude in sintesi
definitive, possiamo fare una troppo rapida carrellata presso i grandi
linguisti del nostro secolo: ricordiamo le celebri distinzioni antitetiche
di Saussure, langue e parole, signifiant e signifié,
diacronia e sincronia, sintagma e paradigma, riformulate in vario modo
da Hiemslev, espressione e contenuto, forma e sostanza, Jakobson, asse
del sintagma e asse del paradigma, Benveniste, linguistica della lingua
e linguistica del discorso, dimensione semiotica e dimensione semantica
- il Marty ispirandosi all'opera di Edmond Ortigues Le discours et
le symbole riconduce il tutto alla tensione fra un polo della determinazione
e un polo simbolico, rispettivamente al rapporto fra significante e
significato e al rapporto dei significanti fra di loro, e in ultima
analisi richiamandosi a Kant alla tensione fra il sensibile e l'intelligibile,
e quindi al fatto primordiale per cui il linguaggio fa senso con ciò
che di per sé non ha senso (15). Questa dualità tensionale
trova riscontro, a suo avviso, nel cuore della riflessione analitica
del linguaggio nella dualità dell'opera di Wittgenstein letta
nel suo complesso e in modo unitario, dualità fra struttura logica
del linguaggio e molteplicità dei giochi linguistici, e, dopo
Wittgenstein, nella dualità di constatativo e performativo nella
teoria degli atti linguistici.
Tale meditazione sulla dualità
è importante per il nostro assunto perché essa ci conduce
alla necessità del pluralismo linguistico, non solo come pluralità
delle lingue, ma anche come necessaria pluralità degli attori
linguistici.
La benedizione di Babele è allora
la rinuncia a una lingua unica, che disconosce le differenze, così
come al mito di una traduzione senza residui, che, se fosse realizzabile,
sopprimerebbe la alterità dell'altro.
Di contro alla pluralità e diversità
delle lingue, che è un ostacolo effettivo alla comprensione,
non c'è la fuga nel mito, lingua unica, traduzione perfetta,
ma il lavoro concreto, faticoso, foriero di risultati sempre parziali,
della traduzione sia nel senso stretto che largo della parola. Così
il germanista francese Antoine Berman può dare al un suo grande
saggio su cultura e traduzione nella Germania romantica giustamente
il titolo di L'épreuve de l'étranger (16).
Così il già citato Zumthor,
grande medievista ma anche studioso di poetica e storia letteraria dai
molteplici interessi, nel suo Babel può fare l'elogio
dell'incompiutezza come segno della finitudine umana, che la lettura
del mito suggerisce.
E infine Paul Ricoeur in una conferenza
dell'aprile 1997 su Défi et bonheur de la traduction (17),
replicata in una versione libera "a braccio" a Napoli, nell'Ateneo
Federiciano, nel maggio dello stesso anno, avvicina il lavoro del traduttore
- servo di due padroni, come diceva Rosenzweig, posto come mediatore
tra l'autore da tradurre e il lettore, secondo Schleiermacher - al lavoro
della memoria e al lavoro del lutto nel senso freudiano della parola
"lavoro". Ciò che viene sottomesso ad una prova (che
comporta anche sempre sofferenza) è il desiderio, la pulsione
di tradurre: dunque d'appropriarsi dell'altro, dello straniero, trasserendolo,
tra-ducendolo nella propria lingua. Il traduttore, dice Ricoeur riprendendo
Berman, forza da due lati. Forza la propria lingua a rivestirsi di estraneità
e la lingua straniera a lasciarsi de-portare nella propria lingua materna.
È una prova che si può
superare solo se si accetta che in questo tragitto qualcosa si perda,
qualcosa debba diventare oggetto di rinuncia (si debba cioè superare
una resistenza, in analogia con la terapia psicoanalitica). Si deve
consentire a perdere la pretesa di autosufficienza della propria lingua
materna (contro le resistenze di ogni sorta di autoesaltazione enfatica
della propria lingua, di imperialismo, di sciovinismo linguistico),
ma si deve anche saper rinunciare alla fantasia di onnipotenza di una
traduzione totalmente adeguata, di una reduplicazione dell'originale.
Qui le resistenze contro cui combattere non sono solo di ordine fantasmatico
ma sono anche tutte le difficoltà reali della traduzione effettiva:
non solo i campi semantici non si sovrappongono, ma le sintassi non
sono equivalenti, l'andamento delle frasi non veicola le stesse eredità
culturali, le sfumature delle connotazioni semi-mute sovravvaricano
le denotazioni fissate nei vocabolari ecc.
Eppure il solo rimedio ad una traduzione
difettosa è una nuova traduzione, sulla base di un minimo di
padronanza di entrambe le lingue, da parte di un lettore competente.
L'ideale di una traduzione perfetta può come ogni ideale avere
un uso regolativo e diventare allora lo stimolo ad una serie di approssimazioni:
dal punto di vista storico sotto le specie di ciò che Lacoue-Labarthe
e Jean-Luc Nancy chiamano l'Assoluto letterario (18) questo
ideale regolativo ha svolto un ruolo nella crescita e nel perfezionamento
di una lingua e di una letteratura particolare. Già il Folena
osservava che molte letterature nascono da traduzioni (abbiamo ricordato
il valore fondativo della traduzione di Lutero per la lingua letteraria
tedesca) : sicché si deve dire in principio fuit interpres
piuttosto che in principio fuit poëta (19).
L'ideale di una traduzione perfetta
ha rivestito altre forme : quella cosmopolitica della biblioteca
totale, del libro di tutti i libri, sogno di una razionalità
universale libera da ogni vincolo, illuminismo pienamente realizzato
e la versione messianica preconizzata da Walter Benjamin della lingua
pura di cui ogni traduzione porta in sé una eco.
In tutte queste figure, per quanto suggestive,
si tratta sempre di un guadagno senza perdita, di un desiderio di pienezza
cui bisogna invece saper rinunciare. L'universalità recuperata
finirebbe col sopprimere la memoria dello straniero e perfino l'amore
per la lingua propria accusata di provincialismo : è la
storia in definitiva che verrebbe cancellata: diverremmo tutti degli
apolidi, senza patria, degli esuli che non trovano asilo in nessun luogo.
Al contrario, assumendo l'irriducibilità
della coppia del proprio e dell'estraneo il traduttore trova la sua
ricompensa e la sua felicità nel riconoscimento dell'insuperabile
stato di dialogicità dell'atto di tradurre (che in questo senso
è pienamente atto di interpretazione). Se Steiner, ma anche San
Girolamo, ricorre a metafore guerresche per caratterizzare il lavoro
del traduttore, l'incontro con l'altro, può avvenire non solo
nella forma dell'hostis ma anche in quella, etimologicamente
affine, come mostra il Benveniste (20), dell'hospes, ma certamente
di assai diversa valenza etica.
"Ad onta del carattere conflittuale,
scrive Ricoeur, che rende drammatico il compito del traduttore, questi
potrà trovare la sua gioia in quella che vorrei chiamare l'ospitalità
linguistica (hospitalité langagière). Il suo regime
è appunto quello di una corrispondenza senza adeguazione. Condizione
fragile che non ammette come verifica che quel lavoro di ritraduzione
che ho richiamato in precedenza, come una sorta d'esercizio di reduplicazione
del lavoro del traduttore grazie ad un minimo di bilinguismo. [...]
Così come nell'atto di raccontare si può raccontare altrimenti,
nell'atto di tradurre [...] egualmente si può tradurre altrimenti,
senza sperare di colmare lo scarto fra equivalenza e adeguazione totale.
Ospitalità linguistica, dunque, nella quale il piacere di abitare
la lingua dell'altro è compensato dal piacere di ricevere presso
di sé, nella propria casa di accoglienza, la parola dello straniero"
(21).
Partendo da una rilettura del mito babelico,
guidata dalla consapevolezza del linguaggio come aspetto imprescindibile
della condizione finita e corporea dell'uomo e della tra-duzione come
paradigma ermeneutico della mediazione fra mondi culturali diversi,
arriviamo dunque alla necessità di elaborare una teoria e una
pratica dell'ospitalità linguistica. In tale prospettiva, il
rimedio contro l'intolleranza non potrebbe essere un generico sincretismo
o un semplice appello ai buoni sentimenti, ma un approfondimento delle
proprie radici spirituali, che renda capace di ascolto e di dialogo
con l'altro, col diverso che può diventare perciò l'amico,
l'ospite, il depositario di un seme di verità che a noi manca
e completa quel frammento che possediamo o crediamo di possedere.
Il breve saggio di Ricoeur sulla traduzione
che mi ha guidato nella parte finale della mia relazione contiene, per
così dire, in miniatura, la memoria globale dell'opera del maestro
francese: dall'antropologia implicita nella sua filosofia della volontà
alla meditazione delle forme molteplici della creatività del
linguaggio, nei lavori dedicati alla metafora e al racconto, passando
per gli studi su Freud - ma soprattutto, la tra-duzione come paradigma
dell'ermeneutica ci introduce in modo privilegiato nella fenomenologia
ermeneutica del Sé, colla sua complessa dialettica dell'identico
e dell'altro, e delle forme plurali dell'alterità nel cuore stesso
del Sé, tema di Soi-même comme un autre.
Se tale prospettiva comporta nuovi compiti
per la riflessione filosofica, compiti che mi piace caratterizzare con
una espressione che prendo in prestito da Bernard Waldenfels, vale a
dire la necessità di ripensare "die Phänomenologie als Xenologie"
(22), vorrei sottolineare che il pensiero di Ricoeur resta, a mio avviso,
un punto di equilibrio prezioso nel dispiegamento di una filosofia della
alterità che non dimentica di essere intrecciata attraverso molti
fili e in modo talora complesso e nascosto, all'itinerario drammatico
e spesso penoso attraverso il quale il Sé, quel Sé che
ciascuno di noi è ed è chiamato ad essere, si conquista
e si realizza nella prassi di tutta una vita, e nella reciprocità
della relazione intersoggettiva.
Se parlare, in conclusione, significa
sempre tradurre, anche allorché parliamo con noi stessi, e scopriamo
le tracce - da cui non si può prescindere - degli altri in noi
stessi, l'affermazione originaria, che rappresenta - secondo Ricoeur
e, rileggendo, alla sua scuola, Aristotele e Spinosa (23), nello spirito
della tradizione riflessiva - lo sforzo o il desiderio di esistere,
o ancora il conatus in cui si esprime il nostro atto costitutivo
di uomini capaci di agire e di soffrire - in breve, il nodo essenziale
della nostra vita e della nostra ricerca d'identità, passa per
un lavoro enorme e mai definitivo di traduzione e di traduzioni, di
ogni sorta di traduzione, che coincide con la storia delle nostre vita,
con la rete infinita delle nostre azioni e passioni, con il lavoro del
lutto e della memoria che tale opera esige, con le sue sfide sempre
rinnovate e con la felicità che essa ha il potere di accordarci
nelle pause del nostro cammino.
1) Die Religion in Geschichte und
Gegenwart , Tübingen, Mohr, 19593, vol. III, coll.
242-262. "Die Vokabel hat drei Bedeutungsrichtungen: aussagen (ausdrücken),
auslegen (erklären) und übersetzen (dolmetschen). Welcher
Bedeutung die Priorität zukommt, ist sprachgeschichtlich nicht
festzustellen. Es handelt sich um Modifikationen der Grundbedeutung
'zum Verstehen bringen', 'Verstehen vermitteln' in Hinsicht auf verschiedene
Weisen des Verstehenproblems" (col. 243).
2) A tal proposito, E. Betti ritiene
"un ingenuo pregiudizio provocato dalla forma mentis delle c.d.
scienze esatte quello di credere che l'espressione adeguata e 'chiara',
mentre rende possibile una intelligenza esatta e sicura, escluda la
possibilità di una intelligenza migliore. Qui, come nell'asserire
che 'in claris non fit interpretatio', si cade in un ysteron proteron
, scambiando per punto di partenza quello che, dato il carattere ellittico
di ogni linguaggio, potrà essere, se mai , un punto di arrivo
e un risultato del processo interpretativo: l'apprezzamento di chiarezza
dell'espressione rispetto al contenuto da esprimere" (Teoria
generale dell'interpretazione, Milano, Giuffré, 1990, vol.
I, pp. 339-340 ).
3) Cfr. J.- L. Chrétien, L'arche
de la parole, Paris, Puf, 1997.
4) Cfr. G. pet, Appaerence and Sense.
Phenomenology or the Fundamental Science and its Problems, Dordrecht-Boston-London,
Kluwer, 1991. pet, che si era perfezionato con Husserl a Gottinga,
dopo aver studiato nella nativa Kiev e a Mosca, ritornato in patria,
prima dello scoppio della grande guerra, fu animatore del gruppo fenomenologico
di Mosca cui appartenevano i giovani Roman Jakobson e Boris Pasternak..
Egli pubblicò già nel 1914 la sua monografia su Il
fenomeno e il suo senso. La fenomenologia come scienza fondamentale
e i suoi problemi, della quale abbiamo citato la traduzione inglese
nella prestigiosa collana "Phaenomenologica", nella quale
veniva proposto una riforma in senso ermeneutico della fenomenologia,
qualche anno prima degli ormai noti corsi del giovane Heidegger a Friburgo.
La promettente scuola russa di fenomenologia che godette di qualche
anno di libertà subito dopo l'Ottobre, fu stroncata dal terrore
staliniano (pet morirà fucilato nel 1937, lasciando numerose
opere edite e inedite tra cui una storia dell'ermenutica di straordinaria
modernità datata Mosca 1918, pubblicata solo qualche anno fa
in russo e in tedesco ; cfr. Die Hermeneutik und ihre Probleme
(Moskau 1918), München, Alber, 1993. Su pet si veda: E. Holenstein,
Linguistik, Semiotik, Hermeneutik, Frankfurt a. M., Suhrkamp,
1976; A. Haardt, Husserl in Rußland. Phänomenologie der
Sprache bei Gustav pet und Aleksej Losev, München, Fink, 1993 ;
M. Dennes, Husserl-Heidegger. Influence de leur oeuvre en Russie,
Paris-Montréal, L'Harmattan, 1998.
5) Cfr. G. Steiner, After Babel.
Aspects of Language and Translation, Oxford-New York, Oxford U.
P., 1975, 19983 (tr. it. di R. Bianchi e C. Béguin,
Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, Milano,
Garzanti, 19942).
6) G. Folena, Volgarizzare e tradurre,
Einaudi, Torino 1991, pp. 5-6.
7) Cfr. G. Mounin, Teoria e storia
della traduzione, tr. it. di S. Morganti, Einaudi, Torino 1965,
p. 18. Questo testo dello studioso francese è stato scritto appositamente
per l'editore italiano.
8) "Any model of communication
is at the same time a model of trans-lation, of a vertical or horizontal
transfer of significance. No two historical epochs, no two social classes,
no two localities use words and syntax to signify exactely the same
things, to send identical signals of valuation and inference. Neither
do two human beings. [...] We speak to communicate. But also to conceal,
to leave unspoken. The ability of human beings to misinform modulates
through every wavelenght from outright lying to silence. This ability
is based on the dual structure of discourse: our outward speech has
'behind it' a concurrent flow of articulate consciounsness. [...] In
the majority of conventional, social exchanges, the relation between
this two speech currents is only partially congruent. There is a duplicity.
[...] Thus a humain being performs an act of translation, in the full
sense of the word, when receiving a speech-message from any other human
being": G. Steiner, op. cit., pp. 47-48 (tr. it. , pp. 74-75).
9) "The hermeneutic act must compensate.
If it is to be authentic, it must mediate into exchange and restored
parity. The enactement of reciprocity in order to restore balance is
the crux of the métier and morals of translation":
ibid., p. 316 (tr. it. , p. 358).
10) "The translation restores the
equilibrium between itself and the original, between source-language
and receptor-language which had been disrupted by the translator's interpretative
attack and appropriation. The paradigm of translation stays incomplete
until reciprocity has been achieved, until the original has regained
as much as it had lost": ibid., p.415 (tr. it., 468).
11) Cfr. F. Marty, La bénédiction
de Babel, Beauchesne, Paris 1990.
12) Cfr. P. Zumthor, Babel ou l'inachèvement,
Seuil, Paris 1997 (Babele. Dell'incompiutezza, tr. it. di S.
Varvaro, Il Mulino, Bologna 1998).
13) Cfr. K. Jaspers, Die grosse Philosophen,
Pieper und Co., München 1957, p. 616 ( I grandi filosofi,
tr. it. di F. Costa, Longanesi, Milano 1973, p. 704).
14) Cfr. P. Ricoeur, "Discours et communication",
in La communication, Actes du XVe Congrès de
l'Association des Sociétés de Philosophie de langue française,
Montréal 1971, Montmorency, Montréal 1973, pp. 23-48;
una traduzione italiana di questo testo è inclusa nell'antologia:
P. Ricoeur, Filosofia e linguaggio, a cura di D. Jervolino, tr.
it. di G. Losito, Guerini, Milano 1994, pp. 111-142.
15) Cfr. F. Marty, op. cit.,
pp. 34 ss. e E. Ortigues, Le discours et le symbole, Aubier,
Paris 1962.
16) Cfr. A. Berman, L'épreuve
de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique,
Gallimard, Paris 1984 (La prova dell'estraneo, a cura di G. Giometti,
Quodlibet, Macerata 1997).
17) In occasione della consegna del
Prix de Traduction pour la promotion des relations franco-allemandes
(Fondazione DVA di Stoccarda), all'Institut Historique Allemand di Parigi,
il 15 aprile 1997.
18) Cfr. Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L.
Nancy, L'absolu littéraire, Seuil, Paris 1998.
19) G. Folena, op. cit., p. 4.
20) Cfr. É. Benveniste, Le
vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit, Paris
1969, vol. I, pp. 87-101, 360-361 (Il vocabolario delle istituzioni
indoeuropee, tr. it. di M. Liborio, Einaudi, Torino 1976, vol. I,
pp. 64-75, 276-277).
21) P. Ricoeur, Défi...,
cit., p. 21.
22) Cfr. B. Waldenfels, Topographie
des Fremden, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, pp. 85-109.
23) Cfr. P. Ricoeur, Soi-même
comme un autre,Seuil, Paris 1990, pp. 365-367 (Sé come
un altro, tr. it. di D. Iannotta, Jaka Book, Milano 1993,
pp. 429-431).