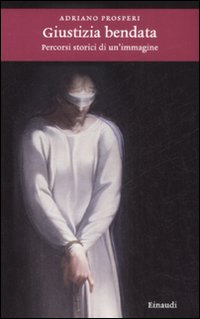|
Adriano
Prosperi
Diversamente dal diritto, la letteratura possiede un’attitudine speciale nel rovesciare le convenzioni, sospendere le certezze(1; ciò che, nel contesto del discorso letterario o di qualsiasi altro discorso, può avvenire in virtù di slittamenti minimi: “una parola al posto di un’altra”, ad esempio, e tutto l’universo delle nostre certezze è pronto a sfaldarsi(2. Nell’incipit di America, ricorda Ost, Kafka ricorre a uno slittamento del genere, descrivendo l’arrivo del giovane protagonista in terra americana : “quando il sedicenne Karl Rossmann -che i poveri genitori avevano mandato in America perché una domestica l’aveva sedotto e aveva avuto un figlio da lui- entrò nel porto di New York a bordo della nave che aveva già rallentato, vide la statua della dea della libertà, che da tempo stava osservando, come circonfusa da una luce solare fattasi improvvisamente più intensa. Il braccio con la spada svettava come se fosse stato appena sollevato e i venti soffiavano liberi attorno alla figura.”(3 Prima di essere preso alla sprovvista, l’ignaro lettore fa il suo dovere di bravo lettore e dunque legge, ma gli occhi della mente hanno subito già un primo shock: si aspettava la fiaccola, nella mano della statua della libertà, e invece vede una spada. All’ottavo rigo del romanzo siamo già disorientati, una certezza è già crollata grazie a un’immagine. Grandezza di Kafka. Che, con le parole, allude a un episodio, banale e tragico al tempo stesso, un “errore di gioventù” del protagonista e, con un’immagine, la spada sollevata (e come sollevata proprio per lui, in “omaggio” al suo approdo in terra straniera), fa intuire all’immaginazione, più che all’intelletto, del lettore l’eventualità (o la minaccia o la promessa) di una punizione. Nel contesto del discorso pittorico, il meccanismo non cambia: un dettaglio inconsueto al posto di un altro e la percezione del soggetto che osserva ne esce turbata. La decisione dell’artista circa il dettaglio inusuale non è mai casuale, ovviamente; se ci si concentra sull’universo dell’iconografia giudiziaria, poi, tale evidenza trova non soltanto conferma, ma anche arricchimento, grazie ai riflessi complessi tracciati dai rapporti tra poteri: potere del sovrano, della chiesa, delle chiese, dei giudici, degli uomini di legge. Riflessi che inevitabilmente, nel corso dei secoli, hanno irradiato di luce, colori e significati quel particolare settore del mondo iconografico. “Giustizia bendata”, di Adriano Prosperi, è un libro importante per più ragioni, al punto che il sottotitolo (“percorsi storici di un’immagine”) appare, a lettura ultimata, riduttivo, perché quei percorsi sono anche, tra l’altro, politici e giuridici. Chiunque sia interessato al tema dei rapporti tra potere politico e potere giudiziario potrà trarre beneficio (e diletto e bellezza) da queste pagine (per inciso: peccato soltanto per la scelta del bianco e nero -un must per gli specialisti, ma non anche per il grande pubblico- a cui l’editore ha voluto condannare l’ampio corredo iconografico del libro e per la qualità delle immagini, che poteva essere migliore). Il lettore avvertito, e non solo lui, conosce bene la crucialità di quel tema per l’Italia di oggi; che le scelte iconografiche relative al mondo della giustizia siano sempre state rivelatrici di precise strategie (oltre che di ideologie) politiche è un dato forse meno scontato che il libro di Prosperi ha il merito di far emergere in piena luce. Il mondo delle immagini della giustizia trova infatti la sua ragion d’essere non solo nel bisogno degli umani di pensare per immagini -che trova certamente nella giustizia “un punto di riferimento speciale”(4- ma anche in strategie politiche volte ora a restringere la sfera di autonomia del potere giudiziario a vantaggio del potere sovrano, ora a secolarizzarlo da ascendenze divine o papali, ora a stigmatizzarne derive, vizi, debolezze. Ciò detto, sarà bene tornare alla potenza dei dettagli e alla loro capacità di aprire squarci improvvisi di luce sulle cose del mondo. Il dettaglio sul quale l’Autore concentra la sua attenzione è quello della benda sugli occhi della giustizia. Un dettaglio a cui ormai i nostri occhi si sono assuefatti, ma che creò, al momento del suo ingresso ufficiale sulla scena dell’iconografia giudiziaria (1494), non poco stupore. In verità, la prima immagine della giustizia bendata che Prosperi propone al lettore(5 è ben meno risalente ed è datata 1904: la fonte è l’Antologia di Spoon River, in cui compare “una donna bellissima, con gli occhi bendati”, epperò malvagia, furente, foriera di sventura e d’iniquità; quegli occhi bendati, “no respecter of persons” (che “non guardano in faccia a nessuno”) erano gli stessi che avevano già decretato la condanna a morte di sette anarchici, in seguito alle manifestazioni del 1° maggio 1886, e che avrebbero altresì condannato il giovane inglese accusato di tendenze anarchiche che Edgar Lee Masters tentò invano di difendere davanti alla Corte Suprema nel 1904. L’immagine della dea bendata, in questo caso, è molto lontana dal significato (d’imparzialità, di distacco) che siamo soliti attribuire a quella necessaria “cecità” rispetto al contesto. Qui benda fa rima con giustizia tremenda. Con giustizia folle. E di follia si parla nell’opera che introdusse nel Continente la novità dell’immagine di una giustizia cieca: l’anno è il 1494 e il luogo d’edizione Basilea, il poema è La Nave dei folli di Sebastian Brant(6; con qualche margine d’incertezza, viene attribuita a Dürer l’incisione che fece storia: la giustizia bendata da un matto (riconoscibile dal berretto a sonagli). In quel poema -destinato a un successo immediato e di lunga durata, che si sarebbe poi inscritto nel solco del genere satirico(7- Brant si avventura in un viaggio fantastico nel paese della Follia, irridendo e stigmatizzando i vizi di chierici, nobili, uomini di legge, giudici; il successo dell’opera si spiega in quanto essa andò ad incunearsi efficacemente in un problema di corruzione dei costumi acutamente percepito in quel tempo(8. La campagna di richiami e moniti rivolti agli operatori della giustizia trovò espressione anche attraverso una nutrita testimonianza iconografica, a testimonianza di una crisi molto forte che affliggeva il mondo della giustizia: è di fine XV secolo, ad esempio, un dipinto di Bosch in cui l’avarizia è rappresentata da un giudice, seduto sulla panca del giudizio, proteso ad ascoltare, da un lato, un litigante dalla borsa piena e, dal lato opposto, ad allungare una mano verso la borsa dell’altro litigante. E ancora: in una Malinconia di Dürer, uno dei simboli-chiave della giustizia, la bilancia, è appesa al chiodo, nel senso letterale dell’espressione; e, in un’immagine dell’Apocalisse, il terzo de I Quattro Cavalieri dello stesso artista è cieco(9. E’ interessante notare il modo in cui l’Autore riconduce le scelte iconografiche della Germania dell’epoca a quanto andava accadendo nel mondo del diritto e, segnatamente, al problema della competizione tra diritto consuetudinario e diritto scritto: agli albori del secolo XVI, si discusse vivacemente a proposito dell’opportunità di codificare le norme penali; all’esito di tale dibattito, trovò formalizzazione la Costituzione penale di Bamberga (1507), un sistema di regole, dunque, scritte, certe e valide per tutti, che si poneva in aperta opposizione al diritto consuetudinario, sempre più spesso accusato di lasciare margini eccessivi alle negoziazioni private e, quindi, all’arbitrio. Tra le immagini che illustrarono la Constitutio penalis di Bamberga, figurava quella di un tribunale in cui tutti i giudici appaiono bendati e forniti -sempre in segno di follia- di berretto a sonagli; e un cartiglio a indicare che “giudicare sulla base di cattive consuetudini che si oppongono al diritto è la vita di questi ciechi folli”.(10 Il messaggio politico era dunque chiaro: il disordine del diritto, la follia e l’accecamento dei suoi operatori, nonché dei fruitori, derivavano dall’ostinazione con cui i giudici (pigri, incapaci, conservatori o semplicemente molto astuti) avrebbero voluto continuare ad applicare le consuetudini, anziché le norme scritte. L’innovazione introdotta con la Costituzione di Bamberga operò dunque sia a livello iconografico, sia nel campo del diritto, sia in quello dei rapporti tra poteri e fu un’innovazione strumentale al rafforzamento del potere del sovrano. A tale scopo, quest’ultimo doveva oscurare i poteri concorrenti, come il potere giudiziario e quello ecclesiastico. Per quel che riguarda quest’ultimo, il vento della Riforma luterana iniziava a soffiare e, presto, avrebbe contribuito a impedire intromissioni dell’autorità spirituale nel campo dell’amministrazione della giustizia(11. Quanto al potere giudiziario, occorreva trovare il modo per delegittimare la casta; e il potere politico trovò il modo di esercitare un’adeguata pressione attraverso la “campagna” -anche iconografica- di moralizzazione della giustizia: il problema della corruzione dei giudici era, evidentemente, solo la punta dell’iceberg, era soprattutto un argomento specioso(12, affermandosi in definitiva come l’arma prescelta dal potere sovrano per ricordare a tutti, giudici compresi, dove risiedesse l’autorità(13. Assai significativo, in tal senso, è il dipinto intitolato “il giudizio di Cambise” (1498), di Gerard David, che può ammirarsi a Bruges (Groeningenmuseum), dove è rappresentata la storia (già narrata da Erodoto) del giudice Sisamne, fatto spellare vivo dal re Cambise perché corrotto. A commento di questo straordinario dittico, Prosperi osserva : “quella realtà -la corruzione dei magistrati- di per sé è di ogni tempo e perciò senza tempo. Ma il concentrarsi di questo tema in un luogo e in un momento particolare è il segno di uno stato d’animo non solo diffuso ma anche alimentato ad arte per giustificare l’avvento di un nuovo rito e di nuove regole. Si trattava di affermare il potere sovrano su quell’altro delicato e fondamentale degli uomini di legge. Le immagini potevano valere come promemoria. La figura del sovrano che nel giudizio di Cambise fronteggia minacciosa il giudice corrotto poteva ricordare ai magistrati di Bruges la concretà realtà del potere di Massimiliano d’Asburgo, imposto sulla città ribelle pochi anni prima”.(14 E a ricordare la concreta realtà del potere provvide anche la scelta della codificazione delle norme penali: è noto, infatti, che la tendenza codicistica si afferma in concomitanza con un potere sovrano forte, accentratore o che voglia affermarsi come tale. Probabilmente, la Costituzione penale di Bamberga non fece eccezione, in tal senso, ponendosi come tentativo di contrastare quel fenomeno che, nell’Ottocento, sarebbe stato poi denominato “particolarismo giuridico”, di cui i giuristi pratici (avvocati, notai, giudici) sono stati spesso, e in ogni tempo, i principali sostenitori, data la loro naturale attitudine per un certo “conservatorismo pratico”.(15 Che le immagini agiscano a mo’ di promemoria o monito, o minaccia, è un dato valido a maggior ragione in un’epoca, come quella attuale, dominata dal potere della vista: la malcelata tensione tra potere del sovrano e potere dei giudici che emergeva dalle scelte iconografiche e codicistiche di cui si è appena detto diviene, nel contesto attuale, evidente, spesso virulenta e, quel che è forse peggio, priva del beneficio della mediazione artistica di cui pure, nel ‘500, ci si dette la pena. Si pensi, per quel che attiene al registro dell’immagine(16, a quel video(17, mandato recentemente in onda da una rete Mediaset, nel quale un giudice scomodo è ripreso in tutta la sua “stravaganza” mentre fa cose “strane”, come, ad esempio, passeggiare per le strade di Milano, attendere il proprio turno dal barbiere e fumare “l’ennesima sigaretta”. Volendo nobilitare l’episodio, si potrebbe osservare che si è qui in presenza di un’interessante rilettura di quell’ “ordre travesti” di cui scrive Jacob, vale a dire quella tradizione -letteraria e non solo- satirica, che affonda le sue radici nel medioevo, e che, con intenti di “moralizzazione”, prese di mira il teatro della giustizia con le sue solennità e col suo inevitabile carico di aspetti maldestri, grotteschi o ridicoli. Il registro (derisorio) scelto dal potere politico-mediatico per presentare al pubblico quel giudice che passeggia per le strade di Milano ricorda molto da vicino il registro linguistico prediletto dal potere psichiatrico un po’ di secoli fa per dar ragione dell’internamento di tal Mathurin Milan, di cui ci dà notizia Foucault, “messo nell’ospedale di Charenton il 31 agosto 1707” perché colpevole, tra l’altro, di “portare a spasso il suo povero spirito per strade sconosciute”.(18 Leggendo un registro d’internamento redatto nei primi anni del Settecento, a Foucault venne in mente l’idea per un libro in cui avrebbe raccolto ritratti e suppliche di persone internate in manicomio, tra Sei e Settecento, solo perché colpevoli di “stranezza” nei comportamenti: “alla minima stravaganza”, osserva Foucault, “si è già nell’abominevole, o almeno nel discorso dell’invettiva e dell’esecrazione”(19. E quel discorso faceva leva sulle parole (che, nel caso di quelle riprese-video, si associano e perversamente accompagnano le immagini); parole che garantivano un “effetto comico, certamente: c’è qualcosa di derisorio nel convocare tutto il potere delle parole e, attraverso di esse, la sovranità del cielo e della terra su disordini insignificanti”(20 (vogliamo pensare alla mise “disordinata” del giudice e ai suoi calzini sfacciatamente turchesi, per esempio?). Ingiustizia e crudeltà del sistema a parte, quel che colpiva Foucault era appunto lo stile di quelle testimonianze psichiatriche, che rivelavano in ogni frase “uno splendore, una violenza che smentisce la piccolezza del singolo caso”; e, nel modo in cui, artatamente, ciascuno di quegli episodi di “stravaganza” diveniva un caso clinico, in quel “teatro così enfatico del quotidiano”, Foucault intravedeva acutamente un “punto d’avvio (...) in cui sono incrociati meccanismi politici ed effetti di discorso”(21. Nella
storia dell’iconografia giudiziaria, parte non irrilevante ha
giocato la pittura c.d. infamante: adoperata, ad esempio, a mo’ di
aggravante delle sentenze dei tribunali, come mezzo, cioè, per
amplificare il messaggio di una “pedagogia della vergogna”(22;
oppure attraverso l’immagine femminile della giustizia bendata da
un matto, o ancora da giudici col berretto a sonagli. Insomma, il
repertorio pittorico è ricco. E, come Giuda ha fatto scuola nella
tradizione pittorica, rendendo eterno il prototipo del malvagio
-contrassegnato, in pittura, dai capelli rossi e dal mancinismo-(23
non è detto che i calzini turchesi non faranno storia, a loro volta,
nella storia delle immagini giudiziarie infamanti (ponendosi come
archetipo di una tendenza tutta nuova che potremmo provare a definire
nei termini di “videocrazia giudiziaria infamante” e che fa leva
sulla nostra fatale distrazione
dinnanzi al piccolo schermo?)(24. Prosperi osserva come, a sua volta, Cesare Ripa -in Iconologia, di fine Cinquecento(27 - citasse Aulo Gellio e, riflettendo sull’elemento discordante costituito da quella “moda” degli occhi bendati, non sapesse darsi risposta. E ancora: verso fine Quattrocento, Mantegna e l’umanista Battista Fiera, dialogando circa il modo ideale in cui rappresentare la giustizia, non ponevano in dubbio gli attributi -antichissimi- della vista e dell’udito; semmai, tornava in evidenza l’antica contesa tra i due sensi, posto che nel diritto romano la testimonianza de audito era stata più importante di quella de visu. Ma, contesa a parte, “gli antichi filosofi e i pii religiosi” del tempo, alla cui saggezza i due avevano attinto nel corso delle loro ricerche, insistevano tutti sulla “vista a cui nulla doveva sfuggire”.(28 Ma se è vero che l’immagine della giustizia bendata non attecchì nella pittura italiana del tempo, è anche vero che quella stessa immagine andava affermandosi almeno come istanza ideale, come risulta da un discorso di Machiavelli redatto in occasione dell’insediamento di un nuovo magistrato (forse nel 1520). Prosperi ricorda come Machiavelli, parlando ai suoi concittadini della grandezza dello stato dei romani e dei greci, ne ravvisasse l’origine nella concezione stessa della giustizia, propria di quei popoli, una giustizia che “difende i poveri e gl’impotenti, reprime i ricchi e i potenti (...) Dovete pertanto, prestantissimi cittadini, e voi altri che sete preposti a giudicare, chiudervi gli occhi, turarvi gli orecchi, legarvi le mani, quando voi abbiate a vedere nel iudicio amici o parenti, o a sentire preghi o persuasioni non ragionevoli, o a ricevere cosa alcuna che vi corrompa l’animo, e vi devii da le pie e giuste operazioni. Il che se farete, quando la Giustizia non ci sia tornerà ad abitare in questa città; quando la ci sia, ci starà volentieri, né le verrà voglia di tornarsene in cielo; e così, insieme con lei, farete questa città e questo stato glorioso e perpetuo”.(29 A parte il monito a “chiudere gli occhi,” appare della massima importanza il passo successivo (citato in corsivo), che parla di un processo di secolarizzazione, di migrazione progressiva dei simboli della giustizia dai luoghi sacri verso zone neutre. Ancora prima (nel 1303, all’incirca), Giotto aveva creato un’interessante rappresentazione della giustizia che, per molti versi, può definirsi laica(30, nonostante il lungo manto (chiaramente ispirato all’immagine della Madonna) indossato dalla donna che la raffigura e pur se il luogo (la cappella degli Scrovegni, Padova) laico non era, così come l’intero ciclo pittorico degli Scrovegni era dedicato al sacro per eccellenza. Eppure, Giotto compie una scelta che si allontana dalla tradizione che voleva la giustizia inserita nel contesto delle virtù cristiane (teologali e cardinali), assicurandole invece una posizione centrale rispetto a queste ultime e, soprattutto, immaginando di non poterla raffigurare se non partendo dal suo contrario: l’ingiustizia. Eliminando la bilancia, Giotto recupera l’antico simbolo raffigurando la giustizia stessa alla stregua di una bilancia, visto che la donna col manto regge un piatto in ciascuna delle mani: nell’uno, vi è un essere alato che incorona un buono, nell’altro un vecchio (egualmente alato) intento a decapitare un cattivo. Già nella raffigurazione della signora incoronata e di lungo manto vestita, Giotto affianca dunque alla giustizia l’ingiustizia; la coabitazione del giusto e dell’ingiusto si ripropone, visto che, di fronte a tale immagine, l’artista rappresenta l’ingiustizia, nella forma di un uomo vestito di toga, che distoglie lo sguardo dalle nefandezze d’ordine vario che si svolgono proprio al di sotto dei suoi occhi. Siamo di fronte a una visione della giustizia che, come è stato notato, deriva, tra l’altro, dall’Etica a Nicomaco di Aristotele; se si tiene presente che Padova sarebbe divenuta, di lì a poco, il maggiore centro di studi europeo sull’aristotelismo, non sembra azzardato ritenere che Giotto sia stato influenzato da tali letture (oltre che da Cicerone e da S. Tommaso d’Aquino, per il quale la giustizia legale era la più nobile tra tutte le virtù morali)(31. Nell’Etica, Aristotele legge la giustizia a partire dall’ingiustizia, affermando che, sovente, l’essere umano giunge a conoscere una disposizione soltanto grazie al suo contrario, alla disposizione opposta; si tratta di una prospettiva che di trascendente non ha nulla, evidentemente, se è vero che la giustizia non può essere compresa nella sua essenza ideale e che l’uomo può conoscere l’azione giusta solo a partire da quella ingiusta.(32 La Giustizia di Giotto si inserisce in uno stile iconografico proprio del contesto dell’Italia comunale, dove il Buon Governo (il riferimento è all’affresco senese del Lorenzetti) e la Giustizia escono dalle chiese per dominare, attraverso immagini sempre più secolarizzate, le rappresentazioni del potere nelle sedi delle città libere e dei comuni(33. Anche in tal caso, le immagini si associano a un programma politico ansioso di un “buon governo” che, ponendo fine alle lotte di parte e alla tirannia dei poteri signorili nelle città, potesse restituire ai cittadini la sicurezza alla vita quotidiana e la prosperità ai traffici commerciali: responsabile e destinatario del buon governo voleva essere il “bene comune”, “cioè nient’altro che la nuova realtà politica del Comune”(34. La scelta figurativa di Giotto in tema di giustizia può essere dunque interpretata come una straordinaria anticipazione di quel processo di progressiva autonomizzazione della giustizia dalle altre virtù cristiane, che avrà luogo dopo il medioevo, dopo un periodo, cioè, nel quale il registro di riferimento in tema di giustizia era stato quello divino(35. In seguito, la diffusione dell’allegoria della giustizia sotto forma di donna bendata, che reca in una mano la bilancia, nell’altra la spada, accompagnerà la secolarizzazione della simbologia giudiziaria e la sua progressiva emancipazione da tutori vari. Di ciò, saranno fedeli testimoni quegli occhi bendati: “negandosi a qualsivoglia gioco di sguardi, la giustizia non deriverà la propria virtù che da se stessa; la sua legittimazione, ormai, è tutta interiore”.(36 Se questo lento processo di laicizzazione dell’iconografia giudiziaria agevolò l’ingresso della dea bendata anche nei luoghi giudiziari, va notato, tuttavia, che quell’immagine in tanto riuscì a imporsi in quanto possedeva, a sua volta, un’ascendenza religiosa che i contemporanei -non solo tedeschi- di Dürer colsero al volo: la benda sugli occhi era già stata propria dell’iconografia del Cristo deriso e bendato (che, non a caso, impegna la prima di copertina del libro di Prosperi) nelle scene della Passione: “l’immagine del Giusto insultato e deriso, processato e condannato, riassumeva ogni critica possibile della giustizia umana”.(37 A proposito di tali ascendenze, Prosperi ricorda il celebre gesto dell’avvocato di Dreyfus che, indicando al giudice il crocifisso, esclamò: “ecco il primo condannato innocente!”.(38Lo Stato laico francese non avrebbe smentito quel portato essenziale della Rivoluzione che è la laicità, ponendo il divieto, agli albori del secolo scorso, di simboli religiosi nei luoghi pubblici(39; per quel che riguarda l’Italia, è noto che il crocifisso, in molte aule giudiziarie italiane, resta dov’era: come la benda allora, il crocifisso oggi continua a parlarci di ascendenze di immediata riconoscibilità per i consociati. A Camerino, nel 2003, un giudice se n’è accorto e, in nome del principio di laicità e della libertà religiosa, ha chiesto la rimozione di quel simbolo religioso (o, in subordine, l’esposizione della menorah ebraica)(40, dando l’abbrivio a una significativa vicenda giudiziaria che lo vedeva più o meno perdente ab initio. Di quelle ascendenze di matrice religiosa occorre tener conto, almeno nel senso che occorre saperne qualcosa in più del rapporto tra luoghi del potere, immagini e simboli (e, in tal senso, il libro di Prosperi è di grande aiuto); ma in pari conto vanno tenuti il principio di laicità e i suoi corollari che stentano ad emergere e ad imporsi sia a livello di scelte legislative sia, alle volte, di opzioni giurisprudenziali. In un famoso e folgorante saggio sul potere psichico delle immagini, Aby Warburg contesta l’approccio formale ed estetizzante all’arte, insistendo sulla “necessità biologica” dell’immagine “come prodotto intermedio tra la religione e l’arte”.(41 La storia dell’iconografia giudiziaria conferma senza dubbio questa tesi. Il dibattito sull’esposizione dei simboli religiosi in luoghi pubblici, come le aule d’udienza e quelle scolastiche, dovrebbe tener conto di insegnamenti siffatti, muovendo dalla consapevolezza che le opere d’arte, cosi come i simboli, si collocano in un punto intermedio tra la coscienza (-conoscenza) magica e coscienza (-conoscenza) logica: un punto delicatissimo in cui “non si crede davvero alla magica vitalità dell’immagine e tuttavia se ne resta prigionieri; dove il simbolo viene recepito come segno e resta tuttavia vivo come un’immagine.(42” Almeno in Italia, quel dibattito soffre invece di molte lacune e va avanti a mo’ di chiacchiericcio indistinto e chiassoso tra uno slogan e l’altro. A detta del luogo comune più irritante, il crocifisso affisso nei luoghi pubblici sarebbe soltanto un simbolo “culturale”, che appartiene alla “nostra” (“nostra”: di chi?) cultura, e non anche religioso. Non è vero. E’ un’affermazione falsa o dettata da ignoranza. Bene ha fatto quel giudice di Camerino a prendere sul serio la questione. Bene farebbero i genitori a non trascurare il potere delle immagini e a pensare che quel simbolo, il crocifisso, viene recepito dai più piccoli “come un segno e resta tuttavia vivo come un immagine.” Per tutta la vita, molto spesso. Ciò che, ad alcuni può andar bene, e ad altri no; pertanto, è necessario sia il dibattito sul punto, sia una più elevata qualità dello stesso, perché la questione è di estrema serietà. “Dio creò il mondo e lo mise in discussione”(43. Niente
come quest’aforisma di Franz Marc -ancora una volta un pittore,
affascinato dagli animali e dal trascendente- ci sembra più
indicato per chiudere queste brevi note in cui si è parlato di un
bel libro sulle immagini (religiose e laiche) di giustizia e di
insidie -antiche e moderne- del potere. (Daniela
Bifulco)
1F. Ost, Mosè, Eschilo, Sofocle. All’origine dell’immaginario giuridico, tr.it. Il Mulino, Bologna, 2007, p. 14. 2Ivi, p. 11. 3F. Kafka, America o il Disperso, tr.it. Feltrinelli, Milano, 2008, p. 31 (il corsivo è nostro). 4A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, Torino, 2008, p. XVII. 5Ivi, pp. XV-XVI. 6S. Brant, La nave dei folli, tr.it. Spirali, Milano, 2002. 7Sul punto, R. Jacob, Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Le Léopard d’Or, Parigi, 1994 (spec. cap. V, “L’ordre travesti”, pp.149-164). 8A. Prosperi, cit., p. 8 ss. 9Le immagini sono commentate da A. Prosperi, cit., alle pp. 119, 30-31. 10Ivi, p. 37. 11Ivi, p. 39. 12Ivi, p. 118. 13Ivi, p. 122. 14Ibidem (il corsivo è nostro). 15G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, il Mulino, Bologna, 1976, p. 33. 16E, per quel che concerne invece il piano giuridico, appare paradigmatica la svolta codicistica che ha investito, tra il 2005 e il 2007, l’ordinamento disciplinare dei magistrati. 17Per il video, v. il sito www.repubblica.it. 18M. Foucault, La vita degli uomini infami, tr.it., il Mulino, Bologna, 2009, p. 9 (il corsivo è nostro). 19Ivi, p. 38. 20Ivi, p. 35. 21Ivi, p. 34. 22A. Prosperi, cit., p. 114. 23Ibidem. 24Di “fatale distrazione” dello spettatore nell’era della sovraesposizione massmediatica scrive P. Virilio, L’arte dell’accecamento, tr.it. Cortina, Milano, 2007, p. 7. 25R. Jacob, op.cit., p. 233. 26Aulo Gellio, Le notti attiche, vol. 2, a cura di G. Bernardi-Perini, Utet, Torino, 2007, p. 1053 (il corsivo è nostro). 27A. Prosperi, cit., p. 34. 28Ibidem, p. 7 e nota 4, p. 12. 29N. Machiavelli, Allocuzione ad un magistrato, in Id., L’arte della guerra, scritti politici minori, cura di J.-J. Marchand, D. Fachard, G. Masi, Salerno Editrice, Roma, 2001, pp. 609-611, cit. in A. Prosperi, op. cit., pp. 44-45 (corsivi nostri). 30Per questa lettura, v. U. Vincenti, La giustizia di Giotto, nell’omonimo volume a cura di F. Marcellan e U. Vincenti, Jovene, Napoli, 2006, p. 69 ss. 31Ibidem. 32Ivi, p. 72 33A. Prosperi, cit., p. 96. 34Ivi, p. 98. 35R. Jacob, cit., pp. 224-229. 36A. Garapon, Del giudicare, tr.it. Cortina, Milano 2007, p. 13. 37A. Prosperi, cit., p. 67. 38Ivi, p. 223. 39Il riferimento è all’art. 28 della legge del 9 dicembre 1905. 40Per la ricostruzione della vicenda giudiziaria, v. P. Vipiana, Neutralità degli spazi pubblici e diritto all’identità religiosa nell’ordinamento italiano: orientamenti giurisprudenziali, in Libertà religiosa e laicità, a cura di G. Rolla, Jovene, Napoli, 2009, pp. 153-160. 41A. Warburg, Il rituale del serpente, tr.it. Adelphi, Milano, 1998, p. 75. 42Il passo è di E. Wind, ivi citato nella postfazione di U. Raulff, p. 110. 43F. Marc, La seconda vista, tr. it., SE, Milano, 1999, p. 68.
|